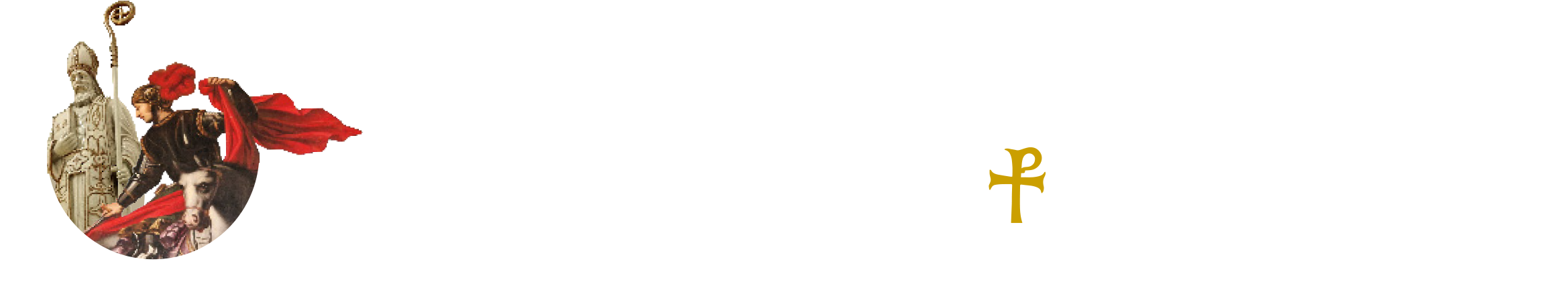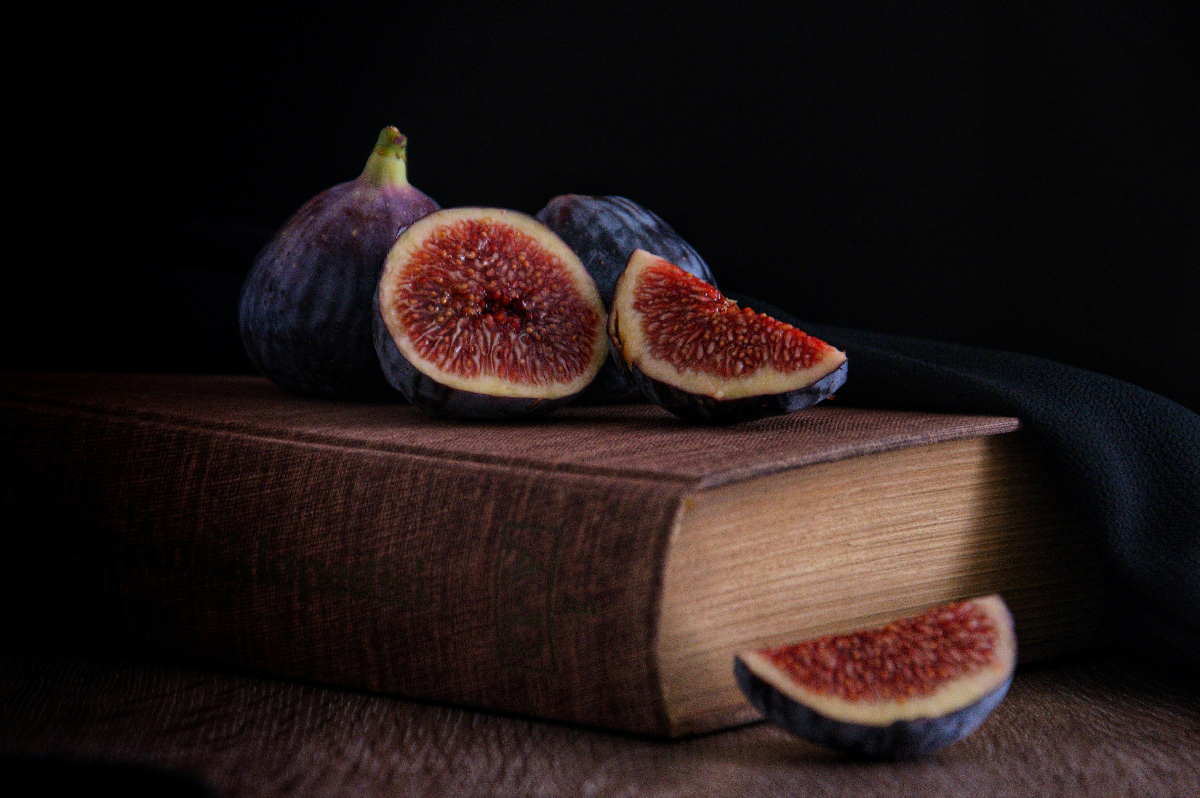Ulisse, Agostino e Leone XIV. Il tempo degli eroi
A settembre ritorniamo a Sant’Agostino, quando fa riferimento all’albero di fico nel contesto della sua conversione: sotto un fico, si rifugiò in preda a una crisi spirituale e ascoltò la voce che gli diceva di prendere e leggere, conducendolo alla lettura di un passaggio della Bibbia che pose fine ai suoi dubbi e aprì il suo cuore alla fede. Questo episodio, descritto nelle sue Confessioni, è un momento cruciale nella sua vita, simboleggia la resa a Dio e la fine delle sue incertezze.
Condividiamo un interessante e originale parallelo, che parte dai versi di Omero alle Confessioni di Sant’Agostino, passando per il pontificato di Leone XIV, descrive come il concetto di eroe attraversa i secoli assumendo forme e significati sempre nuovi. A settembre inizia un nuovo viaggio che parte dalla dolcezza dei fichi e arriva alla ricerca interiore, l’articolo esplora il legame profondo tra l’eroismo classico e la spiritualità, interrogandosi sul significato di “ritorno a casa” e sulla vera natura del destino umano.
Nell’immagine qui sotto:
La conversione di Sant’Agostino, Maestro di Uttenheim
L’episodio del tolle et lege (da un altare a portelle con Storie di Sant’Agostino), 1455 circa, tempera e olio su tavola, Varna, Museo dell’Abbazia di Novacella.
Quest’opera è una delle cose più belle e grandi ispirate alla sua vita. Si vede come è reso bene il fico, le sue foglie e i frutti…

Ulisse, Agostino e Leone XIV. Il tempo degli eroi
La fascia pedemontana della nostra regione è terra di fichi prelibati, piccoli, allungati, dall’aspetto delicato per via della buccia scura quasi un po’ traslucida, spesso ferita da una sottile spaccatura che fa presagire, dentro, la dolcezza del miele.
Quest’anno gli alberi di fichi hanno donato generosamente frutti e ombra, e fra poco le loro foglie grandi, ruvide come la lingua dei gatti, diventeranno gialle e si seccheranno. Per terra sarà un letto croccante di foglie contorte su se stesse, come in un ultimo spasimo.
Ha qualcosa di particolare, questo albero che sa crescere anche da una crepa nel cemento e in poco tempo diventare enorme adattandosi anche agli spazi più ostili. In questa sua tenacia e potenza sembra di scorgere una forza misteriosa, un’eco delle antiche virtù eroiche.
“Ti ho visto sotto il fico”, si era sentito dire Natanaele, quando, trascinato dall’amico Filippo, era andato a conoscere per la prima volta Gesù, il Maestro. Si trattava del primo incontro tra i due, e Natanaele ci era arrivato scettico, quasi solo per accondiscendere all’insistenza di Filippo. Ma Gesù lo aveva stupito: gli aveva confidato di averlo già visto una volta, quando era sotto il fico. Non un fico, un generico fico fra i tanti. Ma il fico.
Abbiamo quindi l’impressione che nel Vangelo quel fico abbia un significato particolare per entrambi, e che la conversazione prenda da qui in avanti una piega strettamente privata. Molte interpretazioni sono state date a questa immagine, ma nessuno come Agostino di Ippona ha saputo dare una spiegazione tanto profonda e viscerale, dedicando alla sua personale esperienza sotto al fico una delle più belle e toccanti pagine mai scritte.
Racconta, infatti, di aver sentito un giorno, improvvisamente, il bisogno di isolarsi, come preso da un dolore interiore profondo, e di aver lasciato il suo amico Alipio, col quale stava seduto a chiacchierare, lì attonito e stupito, senza spiegazioni. Dice poi di essere andato a gettarsi sotto un fico poco distante e, protetto dall’ombra della chioma come a cercare nascondimento, di essersi lasciato andare a un pianto dirotto.
Come non pensare all’entrata in scena di Ulisse nel poema omerico che celebra le gesta dell’eroe? La prima impresa narrata è il suo pianto. E anch’egli, apparentemente, sembra avere tutti i motivi per potersi dire appagato: un luogo meraviglioso come dimora, cibo raffinato, una dea innamorata a sua disposizione. Eppure Ulisse avverte un dolore interiore che è proprio la nostalgia di casa, di ciò a cui sente legato il suo destino. Ogni avventura eroica, in fondo, trova compimento nel ritorno a casa, perché esso è immagine di un rientro nell’anima, in se stessi. Dice infatti Agostino, rivolgendosi a Dio: “Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori”.
La storia dell’uomo è inevitabilmente il realizzarsi di un destino che chiama, di una Itaca che si fa sentire come nostalgia, come sete profonda, come mancanza. E Agostino piange, come ogni uomo che ad un certo punto fa i conti con se stesso. Gli sarebbero mai bastati i piaceri offerti dal mondo, la fama, la ricchezza?
Lì, sotto al fico, urlava il suo dolore buttato a terra, mangiato a morsi dal bisogno di essere saziato interiormente, riconoscendo che tutto ciò che fino ad allora aveva riempito il suo desiderio di essere felice, era stato un inganno. Tutto era servito soltanto per tenerlo fuori da se stesso.
“Quando dal più segreto fondo della mia anima l’alta meditazione ebbe tratto e ammassato tutta la mia miseria davanti agli occhi del mio cuore, scoppiò una tempesta ingente, grondante un’ingente pioggia di lacrime. Per scaricarla tutta con i suoi strepiti mi alzai e mi allontanai da Alipio, parendomi la solitudine più propizia al travaglio del pianto, quanto bastava perché anche la sua presenza non potesse pesarmi. In questo stato mi trovavo allora, ed egli se ne avvide, perché, penso, mi era sfuggita qualche parola, ove risuonava ormai gravida di pianto la mia voce; e in questo stato mi alzai. Egli dunque rimase ove ci eravamo seduti, immerso nel più grande stupore. Io mi gettai disteso, non so come, sotto una pianta di fico e diedi libero corso alle lacrime. Dilagarono i fiumi dei miei occhi, sacrificio gradevole per te, e ti parlai a lungo, se non in questi termini, in questo senso: “E tu, Signore, fino a quando? Fino a quando, Signore, sarai irritato fino alla fine? Dimentica le nostre passate iniquità “. Sentendomene ancora trattenuto, lanciavo grida disperate: “Per quanto tempo, per quanto tempo il “domani e domani”? Perché non subito, perché non in quest’ora la fine della mia vergogna?”. Così parlavo e piangevo nell’amarezza sconfinata del mio cuore affranto. A un tratto dalla casa vicina mi giunge una voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo più volte: “Prendi e leggi, prendi e leggi”. Mutai d’aspetto all’istante e cominciai a riflettere con la massima cura se fosse una cantilena usata in qualche gioco di ragazzi, ma non ricordavo affatto di averla udita da nessuna parte. Arginata la piena delle lacrime, mi alzai. L’unica interpretazione possibile era per me che si trattasse di un comando divino ad aprire il libro e a leggere il primo verso che vi avrei trovato. Così tornai concitato al luogo dove stava seduto Alipio e dove avevo lasciato il libro dell’Apostolo all’atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi tacito il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: “Non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo né assecondate la carne nelle sue concupiscenze”. Non volli leggere oltre, né mi occorreva. Appena terminata infatti la lettura di questa frase, una luce, quasi, di certezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono.”
(Agostino, Le Confessioni, VIII, 12.28-29)
“Ti ho visto sotto il fico”, dice Gesù. Sant’Agostino, come Natanaele, ne ha fatto esperienza. Sotto il fico della vergogna, della consapevolezza della propria miseria, sotto al fico della nostalgia di un bene grande, sotto al fico della solitudine e del bisogno di essere amati, Gesù lo ha visto. E la risposta è stata così concreta da poter essere udita addirittura con le orecchie: “Prendi e leggi”.
Agostino si alza, corre, prende il libro, e legge… mai con tanta avidità ha guardato un libro, mai delle parole scritte gli si sono incarnate dentro come quelle che gli scorrono adesso sotto gli occhi, e non vuole altro, è improvvisamente sazio, totalmente appagato nell’apprendere che non nei piaceri del mondo sta la dolcezza tanto desiderata, ma solo in Cristo Gesù.
Abbiamo la sensazione che se glielo avessero detto, non ci avrebbe creduto. Non così, almeno. Ma Gesù stesso lo ha sedotto sotto al fico.
“Ti ho visto sotto il fico” – dice Gesù ad ognuno di noi – “Ti ho visto mentre eri triste. Ti ho visto quando hai pianto. Ti ho visto quando hai provato quella profonda delusione. Ti ho visto, lì solo e senza risposte. Io sono la risposta”. Ce lo spiega lo stesso Agostino, commentando il passo del Vangelo nell’omelia 7: “Le foglie di fico rappresentano dunque i peccati. Ora, Natanaele si trovava sotto l’albero di fico, come all’ombra della morte. Lo vide il Signore … […] Ma la sua misericordia ti vide prima che tu lo conoscessi, quando ancora giacevi sotto il peso del peccato. Forse che noi per primi abbiamo cercato Cristo, o non è stato lui invece il primo a cercarci?”.
E un uomo che fa questa esperienza di incredibile corrispondenza, che si sente avvolto dall’amore di Dio nell’istante stesso in cui grida il suo bisogno, che prova proprio in senso letterale cosa significa essere visti sotto al fico, non può non affinare una sensibilità particolarissima per la logica di Dio, anche dentro ai dettagli che sfuggono ai più, anche dentro alle parole. Il maestro di retorica e grammatica infatti si accorge che la domanda cruciale di Pilato a Gesù, “Cos’è la verità?”, ha già in sé, nel suo domandare, la risposta di Dio, di un Dio innamorato che non riesce a trattenersi di fronte ad un uomo che lo cerca. Capisce che la domanda di Pilato “Quid est Veritas?” ha già in sé il movimento di Dio verso di lui, perché cambiando semplicemente l’ordine delle lettere appare chiara la risposta: “Est vir qui adest!, ovvero “È l’uomo che ti sta di fronte!”.
“Io sono un figlio di Sant’Agostino”, ha detto papa Leone XIV presentandosi al mondo. La Chiesa ha ora il dono grandissimo di un pastore che eredita tutta l’esperienza di questo grande santo. E’ bello quando incontriamo il figlio di qualche caro amico e speriamo di intravedere, nei suoi, i lineamenti del genitore, o di scoprirne qualche lato del carattere. L’eredità di Agostino è ovviamente immensa, ma essere figli suoi significa anche proporre all’umanità un modo nuovo di stare al mondo. E’ un modo che nobilita l’uomo come mai prima d’ora, lasciando intravedere che proprio a causa delle sue ferite Dio si strugge d’amore nei suoi confronti. È come se fosse arrivato il tempo, per questo mondo ferito, di intraprendere il viaggio di ritorno verso Itaca. È come se fosse arrivato il tempo degli eroi, che iniziano piangendo, e per questo poi arrivano a casa. E’ come se fosse arrivato il tempo di ricordare al mondo che l’amarezza sconfinata del nostro cuore affranto, per usare proprio le parole di Agostino, può essere contenuta nelle braccia di qualcuno!
Leone XIV con il suo annuncio ci ha spalancato una finestra su un orizzonte che forse avevamo dimenticato. Avevamo dimenticato di avere a che fare con un Dio che sembra aspettarci sotto un albero con l’impazienza di un innamorato in procinto di incidere le nostre iniziali sulla corteccia. Avevamo dimenticato di essere così preziosi. Avevamo dimenticato di essere belli e attraenti anche a pezzi o vestiti di stracci.
Leone ci ha commossi confidandoci di essere un figlio di Sant’Agostino, ci ha riportato alla presenza di un Dio innamorato di cui forse avevamo perso la percezione. E le parole di Gesù a Natanaele, “Ti ho visto sotto il fico”, sembrano davvero l’incipit di una storia d’amore, quando qualcuno, con timidezza, si dichiara la prima volta.
Abbiamo un immenso bisogno di cuori infuocati, nella Chiesa e nel mondo intero, di nuovi incendi di amore agostiniano, ovvero senza misura, dove le frecce appuntite attraversano da parte a parte il miocardio, come suggerisce l’emblema dell’ordine agostiniano sullo stemma papale: “Hai ferito il mio cuore con il tuo amore”. In un’epoca complessa come la nostra, caratterizzata da scenari aberranti che forse la Storia non ha mai visto prima, dove la realtà si mescola al virtuale, dove l’intelligenza artificiale si impone sulle relazioni, Leone ci riporta con semplicità all’essenziale. Ci conduce, come figlio di Sant’Agostino, ad un albero che è metafora di un punto di inizio dove l’uomo china la testa, e dove, come Ulisse ci ha insegnato, inizia la storia di un ritorno a casa, di un viaggio che è il vero motivo per cui spendere la vita. “Ti ho visto sotto al fico”, parole sussurrate che già ci sembra di udire nelle nostre orecchie.
LDCB